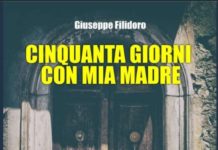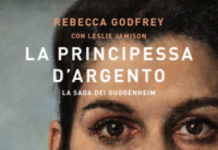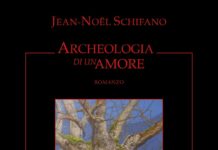Quasi un secolo è trascorso (1929) da quando fu dato alle stampe “Sorelle”, ventuno racconti per altrettanti ritratti di donne, scritto da Ada Negri (1870-1945). Da pochi giorni è in libreria, in un elegante volumetto, con la prefazione di Massimo Onofri per Neri Pozza. Una lettura godibilissima da gustare come si fa ammirando un quadro i cui tratti rapidi e sicuri tratteggiano, con sapienti pennellate descrittive, il carattere e le fattezze dei personaggi.
Ci si può imbattere in un riferimento al modo di parlare: «Il parlare di Nanetta era un volgare ma scoppiettante sfavillio di razzi in una festa campestre» in una confessione allo specchio: «Quante volte nella vita mi sono scoperta a essere un’altra? Pure, se avvicino nel ricordo tutte le donne ch’io sono stata, un solo è il loro volto, un solo il loro cuore» nel quadretto di due anime: «Inconsciamente, i due longevi si misurano: nella stanza angusta, l’aria è resa pesante dalla loro resistenza a vivere» in una comparazione con la Natura che cattura l’anima «Vecchio, divenne più bello che in giovinezza. Nell’alta e magra persona era rimasto dritto come un pioppo d’argine, e alle abbronzate bozze frontali gli ariosi capelli grigi di quel grigio che è luce e non rinuncia, formavano densa corona di vita» o istantanea che cattura l’essenza: «Ma le perle non riescono (né cercano di riuscirvi) a nascondere sotto il mento l’accusa dell’età, che è senza compassione».
Le donne di cui ha scritto Ada Negri sono giovani e meno giovani che vivono l’intervallo tra due conflitti mondiali in un’Italia rurale, o in contesti urbani, in cui l’elemento naturalistico predomina e connota. Un’epoca nella quale si consolida il fascismo e i ruoli femminili sono assegnati: figlie, mogli e madri. L’anelito e la voglia di spezzare l’angusto spazio emergono prepotenti nella determinazione a crearsi luoghi, sprazzi di vitalità, in cui poter esser di più nutrendo il diritto a realizzarsi come persone libere di seguire le proprie inclinazioni e desideri.
Le ambientazioni, la quotidianità dell’Italia centro settentrionale dove il clima è rigido e nebbioso d’inverno e arso da canicola implacabile in estate, fanno da sfondo a brevi racconti in cui i sentimenti e le pulsioni umane emergono decise e nette, alla spensieratezza di ragazze che si affacciano alla vita adulta seguono le abitudini di donne che ne vivono la pienezza e quelle di quante sono intente a guardare indietro, più che innanzi, per il tempo già trascorso.
La produzione letteraria e poetica dell’autrice manifesta il dato autobiografico, le sue origini familiari e le frequentazioni politiche, le idee sociali e una visione del mondo che la portò, oltre che a dar voce alle donne che lavoravano in fabbrica, negli opifici e in ogni contesto nel quale lottavano, anche ad impegnarsi attivamente fondando l’Asilo Mariuccia, un rifugio per donne e bambine vittime della prostituzione.
L’attualità dei temi attraversa ogni pagina snocciolando aspetti del rapporto tra donne e lavoro, donne e doveri familiari di tipo ascrittivo, donne e maternità che sono, ancora oggi, sul tavolo e viene naturale domandarsi cosa sia cambiato a distanza di un secolo.
Il giudizio sulle sue opere è collegato al rapporto che ebbe con Mussolini, iniziato nel periodo socialista e continuato in quello fascista, prima donna ammessa all’Accademia d’Italia la sua vita e le sue scelte sono state fonte di critiche e dibattito. Introspettiva, riflessiva, sagace osservatrice rappresenta un universo femminile ricco e variegato traendolo dall’appiattimento e il grigiore, grazie alla sua penna leggiamo di donne che in un’altra epoca avevano idee, pensieri, desideri e sogni degni di esser raccontati e conosciuti.
© Riproduzione riservata
IL LIBRO
Ada Negri
Sorelle
Neri Pozza
Pagine 187
euro 16
L’AUTRICE
Ada Negri, nata a Lodi nel 1870 da famiglia operaia, maestra elementare e agitatrice sociale, amica di Filippo Turati e Anna Kuliscioff, poi di Benito Mussolini e Margherita Sarfatti, fu candidata nel 1926 e nel 1927 al Premio Nobel per la Letteratura, che sarà assegnato poi a Grazia Deledda. La sua opera è stata discussa con passione e talvolta con risentimento, da Luigi Pirandello e Benedetto Croce, da Giuseppe Antonio Borgese e Renato Serra, da Giovanni Boine e Pietro Pancrazi.