Prima della pausa ferragostana, ultimo appuntamento con la rubrica Bambini e Musei, dedicata al progetto omonimo. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con le scuole dall’artista Luigi Filadoro, presidente dell’associazione culturale étant donnés.
E le soste, si sa, inducono a riflessioni e bilanci. In due anni il progetto ha avvicinato oltre mille bambini e ragazzi alla fruizione dei musei del territorio, e soprattutto lo ha fatto secondo il principio del “prender parte” da protagonisti e non solo da osservatori inerti di “bellezze”.
I bambini e i ragazzi hanno prodotto poster, illustrazioni e guide di musei e hanno aderito oltre 10 scuole di quartieri differenti del tessuto partenopeo; soprattutto, grazie alla collaborazione di alcuni servizi educativi, il museo è stato vissuto con la familiarità di un’aula decentrata per laboratori ed esperienze dirette e pretesto per costruire saperi nuovi e ulteriori.
È motivo di orgoglio apprendere che da più parti si moltiplicano iniziative simili, che mettono in condivisione scuole, bambini, ragazzi ed esperienze estetiche e didattiche. E che soprattutto danno protagonismo alla sensibilità e alla voce degli interessati, considerando compiute anche le incertezze, le imperfezioni e le inabilità che sono inevitabilmente espressione autentica del loro tempo e del loro sguardo.
Il particolare de La parabola dei ciechi di Pieter Bruegel il vecchio, custodito nel Museo Nazionale di Capodimonte scelto per questo breve congedo (foto) prima della ripresa autunnale, sembra quanto mai appropriato. Ci ricorda in maniera precisa quanto la questione dell’arte è sostanzialmente legata allo sguardo, e il buio e l’oscurità (protagonisti del dipinto) sono principi base di ogni forma di creatività.
È l’invisibile l’origine dell’atto creativo che – Derrida insegna – anziché svelare il reale s’immerge nell’abisso del non visibile, da cui trae ispirazione. Circostanza sempre nota ed evidenziata in molti modi da ogni forma d’arte che abbia voluto “interrogare” se stessa e la sua funzione alla ricerca di un metodo e di un sentiero.
Questa “fila indiana” di ciechi che guidano altri ciechi rivela la capacità di Bruegel e di tutta la pittura fiamminga di rendere il grottesco della figura umana; il quadro è un prodigio di tecnica pittorica e rappresenta una delle quattro tempere sopravvissute di Bruegel.
È un tüchlein (pezzetto di stoffa), dipinto con colori ottenuti mescolando pigmenti con una colla solubile in acqua, come i manoscritti miniati prima dell’uso di colori ad olio, ma che a causa della solubilità della colla e dell’alta deperibilità della tela di lino tendono a degradarsi velocemente, con danni difficili da restaurare. La Parabola dei ciechi, invece, è in ottime condizioni ed è datato 1568.
Lo assumiamo come paradigma di una didattica e di un metodo che si generano da quel che non è ancora visibile e sanno correre il rischio di “cadere nel fosso” (come il capofila che non vediamo nel disegno ma nel quadro è a piedi all’aria). In questi tempi che hanno pretesa di spiegare, sapere e condurre.
IL PROGETTO DI LUIGI FILADORO
Bambini e Musei è un’iniziativa di Luigi Filadoro per l’associazione culturale étant donnés (da lui presieduta) che promuove da molti anni percorsi e laboratori finalizzati ad un coinvolgimento concreto e protagonista dei bambini nel patrimonio culturale e artistico, guardando al museo e alle sue collezioni come campo semantico di grande valore ed eccezionale luogo di incontro.
Oltre a potenziare le abilità manuali e creative, il principale obiettivo è promuovere un diritto di inclusione e di cittadinanza intesi come interpretazione, appartenenza e partecipazione alla dimensione storico artistica e culturale che, dal proprio territorio inteso come esperienza e stratificazione complessa di segni e di rimandi, va oltre e diventa metodo e chiave di lettura della complessità, della pluralità e della differenza che ci circonda.
I lavori sono stati realizzati attraverso varie fasi: osservando le opere e realizzando in situazione una copia dal vero, perciò confrontandosi con le difficoltà di “ordinare” in forma grafica qualità percepite attraverso la forma artistica; rielaborando i loro stessi disegni attraverso un collage di carte colorate, con una tecnica suggerita da Depero e dai Futuristi; partecipando, con l’ausilio delle tecnologie e di semplici programmi per l’editing, alla costruzione dello “spazio pittorico” che caratterizza ogni singolo lavoro, frutto di collaborazione di classi intere o gruppi- classe; Attraverso una concreta partecipazione e grazie alla collaborazione dei Servizi educativi dei Musei, sono stati prodotti poster e guide, mettendo quindi i bambini e i ragazzi in una dimensione fortemente comunicativa rispetto ai loro elaborati e partecipando al punto di vista di ipotetici fruitori.
Il progetto “Bambini e Musei” è nato con finalità inclusive e di integrazione, nelle attività curricolari, di bambini e ragazzi diversamente abili e ha avuto inizio al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
L’arte è per sua natura polisemica, portatrice di linguaggi eterogenei e temi universali declinati con modalità differenti, comprende modalità di espressione varie e interconnesse. Perciò è sempre incontro con l’alterità, con l’altro da sé e offre la possibilità di un discorso e un approccio interculturali.
Il museo è luogo privilegiato di dialoghi e relazioni: tra le opere che formano la collezione e tra il fruitore e le opere, in una dimensione di reciproco accrescimento.
PRIMA FOTO DELLA RUBRICA/Piccoli artisti crescono disegnando la dea Artemide, vibrante di luce

19 novembre 2018
Ecco Artemide. Il disegno che pubblichiamo è stato realizzato da bambini del 69° Circolo iidattico di Napoli “S. Barbato” nei mesi di aprile e maggio 2017 nell’ambito del progetto in rete Tutti uguali ma tutti diversi attivato dall’IC “46° Scialoja Cortese” in qualità di capofila. I bambini, in una visita alla collezione farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli si sono soffermati sulla singolare statua di Artemide Efesia.
Copia romana del secondo secolo dopo Cristo, realizzata con materiali diversi, fu ritrovata nella residenza imperiale di Villa Adriana a Tivoli e fu successivamente trasferita da Roma a Napoli dove venne esposta per la prima volta. E’ una delle copie della statua di culto di Artemide venerata nel periodo ellenistico (IV-II° sec. a.C.) nel santuario di Efeso, un tempio enorme considerato dagli antichi “Una delle sette meraviglie del mondo”.
Efeso è una città greca attualmente in Turchia sulle coste dell’Egeo che fu importante e ricco centro di scambi commerciali. La dea è raffigurata in una posizione rigida e dritta e protende le braccia; sul capo ha un alto copricapo cilindrico (polos), a forma di torre con porte ad arco, ai lati del quale emerge un disco, decorato con quattro protomi di leoni alati per parte; il busto regge quattro file di scroti dei tori a lei ritualmente sacrificati, anche interpretati come mammelle, come simbolo di fecondità; sulle gambe la veste aderente è ornata, nella parte anteriore, da protomi di leoni, tori e cavalli alati, all’interno di cinque riquadri sovrapposti; la statua appare ornata da numerose raffigurazioni di elementi naturali e che rappresentano la simbologia legata alla dea.
La presenza di queste sacche, mammelle o scroti di toro, ha avuto molte interpretazioni. Una di queste considera gli oggetti in questione offerte di miele, contenuto in semplici budelli, che i devoti usavano appendere al collo della statua di culto in una versione statuaria più arcaica e realizzata in legno scuro.
Tra gli animali domestici rappresentati sul vestito della dea, infatti, compaiono molte api, donatrici agli uomini dell’epoca dell’unica fonte di zuccheri concentrati. Successivamente, nella versione in marmo, ha conservato queste sacche votive che sono state scolpite come parte integranti della dea.
Artemide, figlia di Zeus e di Leto (o Latona), era considerata l’incarnazione della natura, rappresenta la natura estiva e vibrante di luce. Come suo fratello gemello Apollo, anche Artemide è lontananza e purezza, Incarna la natura incontaminata quindi era una dea vergine e così veniva descritta anche nell’inno omerico a lei dedicato: Artemide pure, la rumorosa dea dal fuso d’oro mai cedette all’amore di Afrodite, dal dolce sorriso.
Artemide così come la natura è ritrosa. Artemide era anche molto vendicativa se trascurata o disturbata nelle sue attività, e in quanto vergine, protettrice della castità; proteggeva le ninfe al suo seguito, ma non esitava a scacciarle se si lasciavano sedurre, inoltre procurava alle donne le doglie del parto e la febbre puerperale, ma contemporaneamente le assisteva nel parto.
Infatti, subito dopo essere nata, fa da ostetrica e assiste la madre nella nascita di Apollo, suo gemello; come ostetrica veniva invocata coi nomi di Locheia e Orsilochia ma, oltre a farli nascere, la dea si prendeva cura dei bambini anche occupandosi di insegnare a curarli ed educarli.

SECONDA FOTO DELLA RUBRICA/ Quell’arte dei presepi tanto amata da re Carlo (di Borbone)
Nelle vecchie cucine della Certosa e Museo di San Martino, di fronte al Refettorio nel bel mezzo del corridoio costruito dal Fanzago per unire il Chiostro dei Procuratori con il Chiostro Grande, la sezione presepiale illustra la magnificenza e l’abilità di un artigianato che a Napoli ha assunto dignità artistica e continua ancora oggi a sorprendere con invenzioni e personaggi dell’attualità che ogni anno si aggiungono alla variegata folla di pastori. Il testo che segue Il testo è tratto dalla guida “ La sezione presepiale, Certosa e Museo di San Martino” pubblicata a giugno 2018 e realizzata con illustrazioni e testi dei bambini delle classi V B e V C del 38° Circolo Didattico di Napoli “G. Quarati” con le docenti Caterina Petrocelli, Annamaria Longobardi, Chiara Campanile, Giuseppina Cappelli.
«La sezione presepiale di San Martino si divide in otto sale; nelle prime due ci troviamo di fronte delle statue molto belle, antiche, dorate ed eleganti. I due personaggi inginocchiati che vediamo in diversi gruppi di sculture dipinte sono la Vergine e San Giuseppe. (…) notiamo una grande scena con una ventina di figure grandi quasi a grandezza naturale che proviene dalla Chiesa di San Giovanni a Carbonara. E’ un presepe fatto dagli scultori Pietro e Giovanni Alamanno verso la fine del 1400 che era composto da più di quaranta figure ma a noi sono arrivate solo quelle che vediamo.
Ci sono angeli e altre figure che stanno vicino alla scena principale e ci sono sembrati molto teneri la Madonna e San Giuseppe che guardano assorti il Bambino (che non c’è!) (…). Qui c’è un bellissima statua in cui Maria riposa solitaria e assorta; è una scultura trecentesca (1320-1325) in legno policromo, donata alle suore del convento di Santa Chiara dalla regina Sancia de Maiorca , moglie del re Roberto d’Angiò.
Il letto su cui riposa la Vergine è abbellito da un lenzuolo con decorazioni a fasce di disegni geometrici, e la statua è di legno colorato (…).
Ci sono altri due gruppi di legno policromo dello stesso periodo che ritraggono San Giuseppe e la Madonna. Sono sculture di Pietro Alamanno e Giovanni da Nola e provengono da due Chiese diverse. Il gruppo di Giovanni da Nola faceva parte di una scena dell’altare maggiore di una Chiesa distrutta e che non c’è più, la Chiesa dei Falegnami. Le due figure sono a “rilievo” cioè sporgono da un fondo piano e non ci si può girare intorno come le altre statue, che si dicono “a tuttotondo”. Continuando nelle altre sale del museo si vedono scene e pastori bellissimi proprio come quelli che vediamo nelle nostre case nel periodo natalizio!
Notiamo subito che la grandezza delle statue è diversa. Tra il 1400 e il 1700 il presepe cambia molto e diventa come noi lo conosciamo, i pastori diventano molto numerosi con l’inserimento di nuovi personaggi, alti 35-40 centimetri e le scene sempre più suggestive. Il presepe napoletano diventa artistico e non c’è famiglia benestante che non ne possiede uno; nascono anche concorsi per premiare il presepe più fantasioso, più originale e più ricco. Le famiglie fanno visita ai presepi altrui, che si costruiscono prima di Natale e vengono smontati il 2 febbraio, giorno della Candelora.
Pare che anche il re Carlo di Borbone amasse passare il tempo a costruire le scenografie per il suo presepe e la regina Amalia a cucire e ricamare vesti per i pastori.
Artisti affermati danno il loro contributo: gli scenografi studiano effetti di luce e luccichii sorprendenti, i musicisti compongono cantate e novene da eseguire davanti ai presepi, i pittori preparano bozzetti e fondali per le ambientazioni, gli scultori e i modellatori plasmano nuovi personaggi molto espressivi, i sarti confezionano piccoli abiti molto preziosi per vestire le statuine.
Dal 1700 in poi i pastori sono snodabili e manovrabili perché non vengono più scolpiti nel legno, ma con il corpo di stoppa annodato su un’anima di fil di ferro, la testa e gli arti in terracotta scolpita e colorata (…).
I mandriani e gli animali sono i primi personaggi che incontriamo. Sono uomini semplici, con vestiti umili e la borraccia di cuoio a tracolla, una coperta sulle spalle e il giacchetto di lana.
Hanno visi molto espressivi e anche molte rughe e si capisce che fanno un lavoro molto faticoso e sono esposti al freddo per badare ai loro animali (…).
Il re Carlo di Borbone (e poi suo figlio Ferdinando) oltre a costruire presepi con piacere governa e fa molte cose per i più poveri, soprattutto per i contadini e gli allevatori. Sviluppa allevamenti di bestiame e aziende agricole nelle tenute di campagna vicino Napoli e importa molte razze di mucche, pecore e capre che si incrociano con le razze locali e danno vita a nuove varietà di animali. Ne troviamo moltissimi, con manti e pelature particolari e modellati con molta precisione. Capre, mucche e pecore accoccolate per terra a riposare, da sole o in gruppi compatti e raccolti a cercare tepore reciproco, che guardano i visitatori con espressione tenera e affettuosa dalle vetrine illuminate del museo (…).
L’Oriente è presente nella scena della Natività con i tre Re Magi e il fastoso corteo che li accompagna.
Nel settecento, quando il presepe ha la sua massima espressione, si diffonde la moda e il gusto per l’orientalismo; il re Carlo di Borbone stipula il Trattato di Costantinopoli nel 1741 con l’Impero Ottomano e ospita presso la sua corte l’ambasciatore straordinario del Sultano. Lo sfarzo delle vesti e degli alabardi, l’armamento dei suoi cavalli, i doni esotici del Sultano al Re, tra cui un elefante dalla zanna spezzata, giraffe e scimmie, le feste e le sfilate di carri trionfali organizzate in città offrono ai napoletani l’immagine di un mondo incantato.
Fantasticando suoni e colori orientali ci perdiamo nelle stanze del museo e incontriamo delle vetrine che si possono guardare da tre lati, dette scarabottoli, con altre scene di presepi.
Contengono la collezione di pastori che gli avvocati Pasquale Perrone e Eduardo Ricciardi hanno donato al Museo (…).
Per concludere incontriamo il presepe Cuciniello che prende il nome da Michele Cuciniello, un architetto napoletano che visse nel 1800, collezionista di pastori del ‘700. (…).
Lo scoglio del presepe Cuciniello è diviso in tre parti, che corrispondono ai tre episodi tradizionali della storia del presepe: il luogo dell’annuncio ai pastori, la Natività, la taverna. La Natività è ambientata tra le rovine di un tempio romano, sormontato dagli angeli; l’annuncio ai pastori, ambientato tra capanne di pastori sorpresi dall’improvvisa comparsa dell’angelo annunciante; la taverna, una casa a due piani con le vivande e i clienti che l’affollano. Nel presepe ci sono 173 personaggi umani, 7 maiali, un coniglio, 2 scimmie, 10 cavalli, 42 angeli e più di 300 piccoli oggetti di ornamento. Il presepe è dotato di un impianto di illuminazione che simula l’alternarsi di alba, giorno, tramonto e notte. Fu inaugurato il 28 dicembre 1879».

TERZA FOTO DELLA RUBRICA/Ave Ovo: così Francesco Clemente celebra al Madre i luoghi d’infanzia. Ma è l’India la sua musa
Con i bambini alla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, in via Settembrini 79, nel cuore della Napoli antica
Realizzato su due piani del Museo Madre di Napoli, il monumentale affresco Ave Ovo è un enorme autoritratto dell’artista napoletano Francesco Clemente e celebra i luoghi cari alla sua infanzia e alla sua memoria.
Si snoda con immagini, simboli e temi tipici della cultura partenopea, per esempio la tombola, e trova il suo punto focale nell’autoritratto dall’artista come San Gennaro, con in mano una maschera di Pulcinella e sistemato al punto di raccordo tra i due piani dell’affresco.
Il pavimento, realizzato da maestranze vietresi della costiera, riporta decorazioni tipiche e nell’impianto generale ricorda un campo di calcio.
Il viaggio è senza dubbio lo stimolo maggiore per la creatività di Francesco Clemente e nei suoi lavori si fa pretesto per raccontare una storia tracciandone solo i punti essenziali. La fascinazione per l’ignoto accresce la curiosità dell’artista e questo riverbera in tutti i suoi dipinti.
L’India è la terra da cui ha tratto maggiore ispirazione. L’artista è stato affascinato dalla cultura mistica del luogo e i suoi aspetti più remoti, tanto da trascorrere parte della sua attività a Varanasi. Allo stesso tempo l’artista è condizionato dalla cultura pop degli Stati Uniti in cui Clemente è riuscito a raccontare le sue ‘storie’ e a fare amicizia con Warhol e Basquiat.
Tutto questo peregrinare, descritto con gli occhi di un testimone e spettatore, è materia viva in questo affresco nel quale ripercorre la sua infanzia napoletana fatta di luoghi e simboli antichi.

QUARTA FOTO DELLA RUBRICA/ Quando il treno diventa oggetto di (re)interpretazione
Se il treno può essere oggetto di (re)interpretazione e rientrare in un discorso estetico… Ecco la terza foto della rubrica dedicata al progetto “Bambini e Musei”, un’iniziativa dell’artista Luigi Filadoro, presidente dell’associazione culturale étant donnés.
I ragazzi dell’ IC “47° Sarria Monti” portano avanti un lavoro sul Museo ferroviario nazionale di Pietrarsa da due anni che ha visto la pubblicazione di poster e di una guida. Di seguito proponiamo uno stralcio della guida realizzata nell’anno scolastico 2017/18 nell’ambito della seconda annualità del programma regionale POR Suola Viva finanziato dalla Regione Campania.
«Con la sagoma imponente del Vesuvio alle nostre spalle ci troviamo in un insieme di padiglioni dove il tempo sembra essersi magicamente fermato: sono i resti di una prestigiosa edilizia industriale, il Real Opificio Borbonico di Pietrarsa che Ferdinando II di Borbone volle costruire in zona Portici subito dopo l’inaugurazione del primo tratto ferroviario d’Italia, la Napoli-Portici, nel 1839, con lo scopo di fabbricare e riparare le locomotive dei treni. In un ampio piazzale in riva al mare, accanto ad una pensilina d’epoca, c’è la statua del re Borbone, un re innovatore e che credeva nel progresso e nelle nuove tecnologie: la costruzione del Real Opificio era inserita in una prospettiva di emancipazione industriale da altri Paesi capaci di gestire le tecnologie di viaggio. Le Officine sono state in funzione dal 1840 al 1977, l’avvento delle nuove tecnologie di locomozione le resero superate e un adeguamento delle attrezzature alle nuove esigenze meccaniche troppo costoso; perciò furono chiuse nel 1977 come cantiere e aperte al pubblico come museo nel 1989.
Padiglione A. Questo magico padiglione è uno dei più grandi e si trova di fronte all’ingresso del Museo. Ospita le più importanti locomotive a vapore, tra cui la Bayard, gemella della locomotiva Vesuvio che inaugurò il primo tratto della ferrovia Napoli – Portici nel 1839. Troviamo anche la carrozza reale con l’elegante tappezzeria di velluto e le rifiniture dorate. All’esterno ci sono i sedili per il personale viaggiante; la carrozza di terza classe è aperta, con panche di legno e si viaggiava protetti da una tettoia e tendine laterali. Sul tetto della carrozza sedevano i frenatori, con l’incarico di arrestare il treno con una manovella che azionava ganasce sulle ruote. Osservando la piccola locomotiva Bayard si possono riconoscere le parti che la compongono: il forno, la camera a fumo, i cilindri e il fumaiolo in nero; il macchinista, il fuochista e lo scaldatore viaggiavano allo scoperto. In coda al convoglio troviamo la carrozza bagagliaio.
Padiglioni B e C. Qui troviamo esposte carrozze e locomotori storici, tra cui una carrozza che fungeva da vero e proprio ufficio postale. Risale all’epoca sabauda, in cui il servizio postale non era ancora organizzato con uffici sul territorio, il treno postale arrivava nelle stazioni e i cittadini potevano usufruire di servizi postali come vaglia o raccomandate. Accanto c’è un’altra carrozza speciale, una cellulare del 1913 per il trasporto di detenuti. E’ composto da celle di 60 centimetri di larghezza, individuabili dall’esterno da lucernari e prese d’aria. Altra particolarità è il treno Centoporte, che consentiva ai viaggiatori di accedere direttamente al loro posto. Il gioiello di questo padiglione è la carrozza Salone del Treno Reale, il treno utilizzato per il matrimonio di Umberto di Savoia con Maria Josè del Belgio. Il treno passò alla Presidenza della Repubblica.
Gli interni molto lussuosi, hanno il soffitto decorato in oro zecchino con plafoniere in vetro di Murano e un fascione sul quale sono riprodotti gli stemmi delle maggiori città italiane. La tappezzeria è di velluto damascato e tutta la boiserie è in legno di ciliegio. Al centro c’è un tavolo di mogano della lunghezza di otto metri realizzato in un solo pezzo. Vi potevano sedere ben 26 commensali. Maniglie e griglie di copertura dei caloriferi sono in bronzo finemente decorato. Vicini al salone più grande ci sono i due salottini con tutti i comfort, riservati al re e alla regina. Il convoglio era attrezzato per avere un’autonomia di tre mesi e comprendeva una vettura in cui erano custoditi tutti i pezzi di ricambio necessari per l’immediata riparazione del treno. Fu donata al Museo di Pietrarsa nel 1989 dal Presidente Francesco Cossiga. Andando avanti incontriamo le Littorine, un vero e proprio gioiello dell’industria tranviaria; assomigliano più ad un autobus che a treni, con la tipica linea arrotondata e parafanghi bombati sulle ruote. (…)
Il nostro racconto di questo straordinario e affascinante museo termina con il padiglione più antico del complesso, il Padiglione G, noto come “la Cattedrale” per gli imponenti e magnifici archi a sesto acuto che gli conferiscono un aspetto suggestivo e maestoso. Costruito nel 1840, vi sono collocati arredi di stazione di ottima fattura artigianale e modelli a grande scala di stazioni e treni. Qui è posto anche il grande plastico Trecentotreni, lungo 18 metri e largo più di due, una vera attrazione per i bambini che visitano il Museo. Al centro delle due navate troviamo la prima motrice verticale a vapore costruita nel 1846».

QUINTA FOTO DELLA RUBRICA/Il fascino della Storia nel cortile delle carrozze di San Martino
La carrozza che riproduciamo è stata realizzata nell’ambito del laboratorio finanziato dai fondi POR Scuola Viva all’Istituto Comprensivo “49° Toti Borsi Giurleo” del quartiere Ponticelli a Napoli.
Luogo di fascino e grandi fantasticherie per i bambini, il cortile delle carrozze della Certosa e Museo di San Martino conserva due esemplari di berline reali tra le più belle giunte fino a noi.Si trovano nell’androne che collega il Chiostro dei Procuratori con i giardini della Certosa e hanno sullo sfondo lo splendido panorama che si gode dal Museo.
L’origine delle carrozze si perde nei secoli; già le popolazioni preistoriche poi gli antichi romani utilizzavano carri a trazione animale.
Nel Medioevo, invece, se ne fece un uso limitato. Tuttavia si ha notizia di mezzi simili a carrozze già nei documenti che testimoniano l’ingresso trionfale a Napoli, nel XIII secolo, effettuato da Beatrice d’Este, moglie di Carlo I d’Angiò, su un carroccio ricoperto da un drappo elegantemente decorato e l’ingresso a Milano nel 1271 di da papa Gregorio Xa bordo di una carretta chiusa da vetri.
Nel 1300 un esemplare di carrozza chiusa venne progettato e realizzato in occasione delle nozze di Galeazzo I Visconti e di Beatrice d’Este. Da quel momento l’uso della carrozza si diffuse ma soltanto tra le famiglie nobili; pare che Galeazzo Maria Sforza diventò collezionista e ne possedesse addirittura una dozzina.
Fino alla metà del 1400 andò di moda la veronese, cioè una carretta chiusa con un’unica cassa appoggiata sull’asse. Poi si diffuse dall’Ungheria un nuovo modello che prevedeva la sacca sospesa all’asse tramite cinghie e catene, che prese il nome di cocchio dalla località ungherese di Kocs in cui nacque.
Nel cinquecento si sperimentarono sistemi di sospensioni a molle, che però crearono molti inconvenienti soprattutto a causa delle strade sconnesse. In Francia la carrozza si diffuse molto lentamente e nel 1500 a Parigi esistevano soltanto tre esemplari, mentre nello stesso periodo in Inghilterra questo veicolo era ancora sconosciuto.
In Italia possedere una mezzo simile divenne una vera moda e, dalla metà del XVI secolo, le industrie ferraresi divennero le più rinomate produttrici per il mercato internazionale.
A Milano l’utilizzo era regolamentato a uso esclusivo dei nobili, negando l’uso ai borghesi e a Roma il papa Sisto V limitò l’uso del mezzo per l’eccessivo rumore. Nonostante tutto l’impiego della carrozza divenne sempre più ricercato e, talvolta, un vero motivo di ostentazione come la carrozza di gala realizzata per le nozze di Odoardo I Francese, che pesava ben sette quintali ed era capace di ospitare a bordo otto passeggeri. Nel 1556 la mania di ostentare carrozze sempre più ricche e impreziosite da bellezze artistiche costrinse le amministrazioni di alcune città, per esempio Bologna e Mantova, a introdurre un’ordinanza che limitasse l’impiego di ornamenti.
Secondo attendibili testimonianze storiche la prima carrozza dell’epoca moderna con abitacolo chiuso da sportelli dotati di vetri nacque a Berlino nel 1670, su invenzione dell’architetto piemontese Filippo Di Chiese. Abile progettista che si occupò principalmente di realizzazioni architettoniche tra cui il castello di Glienicke, fu architetto di corte presso Potsdam, vicino a Berlino, al servizio del principe elettore Fderigo Guglielmo di Brandeburgo. Per suo volere Filippo Di Chiese realizzò questo primo modello di carrozza che, forse per la vicinanza alla capotale tedesca, venne chiamata “berlina”.
Da allora, l’utilizzo della carrozza vide il suo apice divenendo il nuovo simbolo borghese con una diffusione capillare in tutta Europa e nel nuovo mondo in svariate versioni. Sempre alla fine del Seicento, in Italia,Milano conquistò il primato della sua diffusione con oltre 1.600 berline circolanti, costringendo le autorità a formulare i primi regolamenti stradali.
Ma a parte la storia delle carrozze come mezzo di trasporto, antenate del tram e del bus dell’epoca moderna, la carrozza è presente nelle fiabe e stimola l’immaginario dei bambini come mezzo di trasformazione, che traghetta un cambiamento di status, per esempio dalla povertà delle masserizie allo sfarzo del ballo di corte per la gatta Cenerentola che compare per la prima volta ne “Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille” di Gian Battista Basile, noto anche come Pentamerone.
Ma torniamo alla Certosa e Museo di San Martino, la più antica delle due carrozze che possiamo vedere, la Carrozza della città, fu realizzata in legno dorato ed arricchita da dipinti e pregiati tessuti tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo. Fu donata al Museo, nel 1869, dal Municipio di Napoli. Commissionata dal Tribunale di San Lorenzo, alla fine del ‘600, oltre a rappresentare il meglio della manifattura di carrozze, che si sviluppò a Napoli dalla seconda metà del ‘600 fino agli ultimi decenni del ‘700 è l’esemplare più antico di carrozze reali.
Realizzata su ordine del Tribunale di San Lorenzo per trasportare gli Eletti della Città, veniva utilizzata per le cerimonie ufficiali, come le processioni del Corpus Domini, e uscì per l’ultima volta nel 1861. Ha un ruolo simbolico nella storia del popolo napoletano, essendo legata alle più importanti parate che avevano luogo nella città, prima fra tutte quella di Piedigrotta, raffigurata in alcuni dipinti settecenteschi, come quello attribuito a Tommaso Ruiz che si conserva nello stesso Museo di San Martino. Anche per la processione del Corpus Domini, fino al 1861, veniva utilizzata la carrozza degli Eletti.
Da studi e documenti si evince che questa berlina, agli inizi del secolo XVIII ebbe una serie di interventi, tesi ad attualizzarla ai dettami dello stile del tempo.
Tutte le superfici lignee della pesante struttura recano motivi decorativi intagliati e dorati, per lo più di carattere vegetale o simbolico, alludenti alla città partenopea.
L’imponente cassa , dalla linea slanciata, a diamante, reca alla sommità un fregio in bronzo dorato con figure allegoriche, motivi floreali e gli stemmi di Napoli. Anche al centro delle portiere sono applicati degli scudi bronzei, in origine dipinti, e vasi in lamina metallica decorata.
Gli interni, probabilmente rifatti alla fine del ‘700 e nei primi anni dell’800, sono in velluto rosso di seta damascata con nappe e galloni in fili di seta dorata e tendine di raso in seta ai finestrini.
La Berlina di corte appartenne invece alla regina Maria Cristina di Savoia ed è databile tra fine Settecento e inizi Ottocento.
Nel 1886, durante una risistemazione del museo, l’ambiente fu pavimentato e coperto; in questa occasione furono collocati alle pareti gli Stemmi di provenienza reale e vicereale. Alcuni di questi provengono dalla Porta Medina, distrutta nel 1873, e giunsero a San Martino nel 1889; lo Stemma dei Borbone delle Due Sicilie, fregiato del collare dell’Ordine di San Gennaro, proviene dalla porta d’ingresso di Castel Nuovo.
Sul lato sinistro dell’androne si conserva la Colonna della Vicaria, originariamente collocata all’ingresso di Castel Capuano, e dinanzi alla quale nel XVII e fino al XVIII secolo venivano esposti ed umiliati i debitori insolventi, come si vede nel celebre dipinto di ignoto del Seicento Il Tribunale della Vicaria esposto nello stesso Museo. Insomma, San Martino val bene una visita.
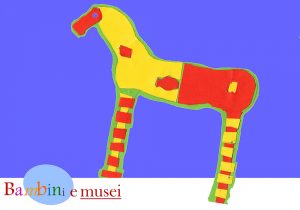
SESTA FOTO DELLA RUBRICA/Quel cavallo sul tetto che rapisce la fantasia in un viaggio imprevisto
Conosciamo circa 300 razze di cavalli, mammifero di grossa taglia che ha cominciato la sua evoluzione 55 milioni di anni fa ma, poiché l’arte ha facoltà di trasgredire l’alfabeto delle immagini e del conoscibile, da qualche decennio circola un altro cavallo di forma e materiali elegantissimi, che sosta in luoghi decisamente inconsueti e che non ha altra funzione che la meraviglia del suo apparire. E’ il cavallo di Mimmo Paladino, nato forse dalle illustrazioni di un libro di fiabe molto antico, e che ha fatto il giro del mondo per sostare in musei, giardini, tetti e pendii panoramici.
Solitario e riflessivo, indossa una maschera e osserva altero scorci e piazze. Nella “Montagna di sale”, installazione dell’artista al Baglio Di Stefano a Gibellina, città siciliana che raccoglie a cielo aperto opere in permanenza di numerosi artisti, la montagna è a forma conica, di altezza tale da poter coinvolgere lo sguardo dello spettatore fino alla cima e a base molto larga, sulla quale si dibattono trenta cavalli disposti in varie posizioni dando vita ad un’affascinante dimensione teatrale.
L’opera nasce nel 1990 proprio come scenografia teatrale de “La sposa di Messina” in occasione delle Orestiadi di Gibellina, e da allora duplicata in altri luoghi e piazze, tra cui Milano e Piazza del Plebiscito a Napoli nel 1995.
A proposito di quest’ultima il filosofo americano Arthur Danto scrisse “[…] debbo affermare l’eminenza di Mimmo Paladino tra le file dell’arte contemporanea, qualità particolarmente vera per le installazioni all’aperto. Non c’è niente che regga il confronto con l’imponente “Montagna di sale” che l’artista ha eretto in piazza del Plebiscito a Napoli, disseminata di cavalli arcaici; il mondo dell’arte dell’ultimo quarto di secolo non ha nulla di paragonabile […]”.
Anche sul tetto del Museo Madre di Napoli un cavallo assorto si staglia sul panorama circostante. L’opera presenta alcuni bassorilievi inseriti sulla superficie scultorea realizzata in blocchi regolari di tufo che ricordano l’opus quadratum degli antichi romani, con un forte ed evidente richiamo ad elementi architettonici: il tufo delle cave etrusche, delle catacombe e ipogei d’epoca greco-romana, delle città scavate nella roccia in varie parti del mondo e quasi dominante nella città di Napoli.
L’apparizione di questo cavallo in un luogo assolutamente improbabile, la terrazza del Museo, ha rapito i bambini in un viaggio affascinante e imprevisto fatto di citazioni e rimandi che lo hanno restituito in una interpretazione inedita e fantasiosa.
La scultura evoca un universo arcano e primitivo di cavalieri e migrazioni, viaggi e guerre, immagini letterarie e stilizzazioni funerarie provenienti dal mondo etrusco, tipico della poetica di Paladino che tesse il filo della storia e delle sue rappresentazioni iconografiche in un progetto contemporaneo di decontestualizzazione e ri ambientazione in contesti architettonici.
Il cavallo riveste un ruolo e una funzione simbolica molto importanti nell’immaginario dei popoli. Simboleggia la forza dell’energia pulsionale e domarlo significa organizzare il magma caotico delle istanze inconscie dell’individuo. Presso i Greci il cavallo, protetto da Poseidone, era associato al Sole e trainava il “carro del cielo” condotto da Apollo, Mitra ed Elia responsabile delle varie posizioni che l’astro assumeva nel cielo.

SETTIMA FOTO/La villa di Caius Olius Ampliatus a Ponticelli: visite guidate organizzate dagli alunni del Porchiano Bordiga
Pochi sanno che a Ponticelli esiste un ritrovamento archeologico molto prezioso, che è la testimonianza della catastrofe provocata dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C. più vicina all’antico centro urbano di Neapolis.
Si tratta di una fattoria appartenuta a un veterano di Silla, Caius Olius Ampliatus, sepolta dall’eruzione e ritrovata durante i lavori di costruzione del Lotto Zero, un agglomerato di abitazioni progettato insieme al Parco Conocal e al Parco Galeazzo per ospitare gli sfollati di varie zone del centro dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980.
Il territorio di Ponticelli, quartiere della zona est di Napoli collocato alle pendici del Vesuvio, fin dalle epoche più remote ha sempre goduto di un terreno fertile, grazie anche alla presenza del fiume Sebeto.
Era un comune a se stante fino al 1926, con forte connotazione agricola e occupato solo in minima parte dal tessuto urbano. Vaste aree erano coperte di orti, giardini, masserie e casali che degradavano verso la costa. Questa conformazione oggi è irriconoscibile, perché l’urbanizzazione recente ha quasi cancellato il vecchio centro storico e ogni traccia dei molti casali e canali che arricchivano i fertili terreni posti alle falde del Vesuvio.
I bambini e i ragazzi di una scuola del territorio, l’Istituto Comprensivo 83 Porchiano Bordiga hanno adottato questo sito archeologico da vari anni: organizzano visite guidate, hanno ricostruito un plastico in 3D e realizzato una guida per i turisti. Tutta la casa, simile nella tipologia alle ville agricole coeve di Ercolano, Pompei, Stabia e Boscoreale, ruota attorno a un cortile porticato centrale (perystilium) retto da colonne in laterizio, che ha una pianta quadrangolare a “U” ed è divisa in due parti, una residenziale (pars urbana) e una produttiva (pars rustica).
Nella parte residenziale c’è un cubiculum, a forma rettangolare con un pavimento in finissimo opus signinum e parete affrescata, comunicante con un altro piccolo ambiente, l’alcova, entrambe destinati al riposo, la latrina e la culina e forse un piccolo quartiere termale.
Il porticato è fatto di muretti bassi ricoperti d’intonaco rosso, costruiti con opus incertum, mentre in altri punti appare costruito in opus reticulatum. La stanza più grande della zona residenziale, riservata ai padroni, il triclinium era destinato ai banchetti e aveva una grande finestra che affacciava sul Vesuvio. E’ stato possibile, dai resti ritrovati, ricostruire lo schema della decorazione pavimentale. Alle spalle del salone si apriva l’aia per l’allevamento dei piccoli animali da giardino e si estendevano i vigneti che al momento dell’eruzione non erano coltivati.
Il portico centrale separava la zona residenziale da quella produttiva dove c’era, invece, l’oletum, ambienti destinati alla produzione di olio in cui erano sistemati l’antico frantoio per la produzione dell’olio e della pasta di olive, il pistrinum, in cui c’era una macina in pietra per il grano e il forno per cuocere il pane, la grande stanza in cui era collocato il torcularium per la premitura dell’uva. All’esterno si apriva la cella vinaria, coperta da una tettoia, nella quale erano collocati i grandi dolia per la fermentazione del vino.
La cella vinaria della villa di Ponticelli si presenta come un vasto locale a pianta rettangolare (25 x 10 m) e come in altre ville dell’area vesuviana era scoperta. Il piano della cella è costituito da terreno battuto in cui erano parzialmente sotterrati ventisei doli che sporgevano in superficie con la sola bocca (dolia defossa).
I doli, contenitori di terracotta di forma sferica usati nell’antichità, non hanno sistemazione regolare: alcuni sono stati sistemati a 20 cm l’uno dall’altro, mentre in altri i contenitori quasi si sfiorano. Si capisce che nel corso degli anni alcuni dolia sono stati riparati, mentre altri sono stati sostituiti e sistemati alla rinfusa senza rispettare alcuna simmetria. Tutti i recipienti erano sigillati con gli opercola su cui erano sistemati i tectoria, scudi di terracotta di 3 cm di spessore a forma leggermente convessa, di diametro di circa 80 cm, sistemati sui coperti per protezione e che non sono stati ritrovati perché disintegrati dal crollo delle pareti della villa dovuto all’onda d’urto del flusso piroclastico durante l’eruzione.
Completavano la parte produttiva altri piccoli ambienti in cui si rinvennero anfore lavate e messe ad asciugare, un piccolo stanzino in cui sono stati trovati frammenti di catene (forse per legare gli schiavi ribelli) e la stalla.
Ben conservate, inoltre, sono le pietre su cui si poggiavano i cardini del grande portone d’ingresso e la cantina alla quale si accede tramite una stretta scala posizionata all’esterno della struttura.
Durante lo scavo della cantina, all’interno di una delle stanzette è stato ritrovato lo scheletro di un uomo che al momento dell’eruzione si trovava nella villa e aveva tentato di ripararsi proprio là sotto, pensando di sfuggire ai gas e ai vapori ardenti.
Questo scheletro ha i pugni chiusi perché è stato ucciso dalle alte temperature della nube ardente. Accanto a lui sono stati rinvenuti resti di cibo, un’anforetta e un anello con un sigillo sul quale si legge “(sono di) caius olius ampliatus”. Poiché lo scheletro appare abbastanza malridotto (con molte ossa rotte e denti caduti prima della morte) si pensa che appartenesse a un servo che gestiva la fattoria al posto del padrone. In effetti, al momento dell’eruzione, le persone che vivevano in quella zona e in tutta l’area vesuviana stavano avendo molti problemi a causa dei frequenti terremoti e, pur non sapendo bene cosa stava succedendo, spesso abbandonavano le loro terre per la paura. Questo spiega perché nella villa di Ponticelli è stato trovato solo un corpo.
L’intero quartiere di Ponticelli è stato il primo a sorgere nel territorio partenopeo ed è nato come terra agricola; in un secondo momento, nel ‘600, da granaio della capitale del Regno si è tramutato in una città a sé.
Fino al 1926 è stato un comune autonomo, come testimonia la pianta urbana mono centrica che tuttora mantiene. Le prime notizie si ritrovano in piena età medievale, intorno all’ XI secolo: si parla del cosiddetto “Ponticello”, come viene definito nelle fonti, un piccolo agglomerato di casali rustici circondati da campi coltivati.
Nel XIII secolo viene costruita quella che sarà la prima basilica cristiana non solo di Napoli ma di tutta l’area vesuviana: la Basilica santuario di Santa Maria della Neve, patrona del quartiere, successivamente decorata con numerose opere d’arte. Durante il Regno di Napoli il sito urbano di “Ponticello” diviene un piccolo borgo: la denominazione plurale di “Ponticelli” nasce dall’unione di “Ponticello grande” e “Ponticello piccolo”, due frazioni nate dall’ampliarsi, negli anni, del villaggio.
In età aragonese lo sviluppo del casale di Ponticelli va di pari passo con quello di Napoli, poiché si adattò alle esigenze napoletane, fungendo da mulino e rifornitore di grano per la capitale ed il resto dell’hinterland: principale alimento delle nostre zone, non era possibile coltivare negli orti all’interno delle mura della grande città tutto il frumento necessario che serviva alla popolazione., Ponticelli è uno dei centri protagonisti dei fatti avvenuti nel 1799, anno della rivoluzione napoletana, che seguirono la resa di Napoli alle truppe francesi: è qui che furono eseguite le condanne a morte di tredici uomini legati a Ferdinando IV da parte dei repubblicani.
Lentamente il piccolo complesso abitativo agricolo si sviluppa e si estende. Nel XIX secolo la nuova classe borghese napoletana decide di stabilirsi in quest’area e necessita di nuovi spazi: Ponticelli conosce un periodo di massiccia espansione edilizia, dovuta anche alla volontà di risanare vecchi tratti del tessuto urbano.
Nel secondo dopoguerra, intorno agli anni ’50, viene dato il via alla ricostruzione del quartiere. Questo periodo è tristemente noto per essere teatro della speculazione edilizia avuta con l’amministrazione del sindaco Achille Lauro: sorsero centinaia di edifici adibiti ad uso abitativo che in seguito formeranno i rioni più popolari, primo tra tutti il Rione De Gasperi, il simbolo di una urbanizzazione in negativo che entrerà prepotentemente nelle cronache cittadine per essere una delle roccaforti del malaffare di Napoli orientale.
Non mancano tentativi di rigenerazione urbana negli ultimi anni, con la realizzazione di enormi Murales nel Parco Merola (Ael, Tutt’ egual song ‘e criature di Jorit Agoch, ‘A pazziella man ‘e criature di Zed1, Chi è vuluto bene nun s’o scord di Rosk&Loste, Lo trattenemiento de’ peccerille di Mattia Campo Dall’Orto) e la riqualificazione della facciata del Palazzo sede dell’ex ARIN, oggi ABC, che coinvolge anche la rotonda stradale di Via Argine ad opera dell’artista Daniel Buren. E la costruzione dell’Ospedale del Mare, proprio di fronte al Lotto 0 dove c’è la Villa di Caius Olius Ampliatus.
In foto, il disegno dei bambini dedicato alla villa di Ponticelli
© Riproduzione riservata










