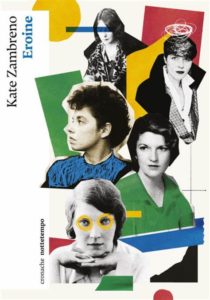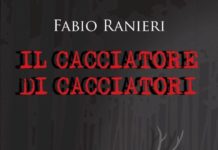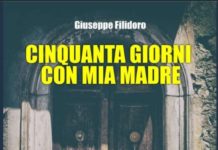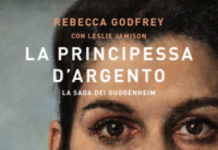Chi decide cosa è letteratura? A chi spetta selezionare la buona scrittura, quella che vale la pena far conoscere e tramandare ai posteri, da quella minore o di nessuna importanza? In “Eroine” di Kate Zambreno, pubblicato da Nottetempo, ho trovato così tanti spunti di riflessione che alla fine della lettura la copia del libro straripa di post it, note, appunti e sottolineature.
L’analisi dell’autrice prende l’avvio dalla storia delle mogli degli scrittori del modernismo passati alla storia come i grandi scrittori del Novecento che, affettuosamente, definisce “le mie mogli pazze” ovvero Zelda Fitzgerald, Vivienne Eliot, Jane Bowles, Jean Rhys.
Cosa accomuna tutte loro? L’aver tradito le aspettative sociali di brave mogli e madri infrangendo le regole di condotta della propria epoca: avevano la pretesa di scrivere, di essere autrici – e non personaggi – nei libri scritti dai rispettivi mariti.
Pretesa non accettabile che fu stroncata con l’ausilio della psichiatria: queste donne erano pazze, andavano curate e rinchiuse: «Nel “programma di rieducazione” del dottor Forel Zelda fu allenata di nuovo al ruolo di brava madre e moglie (il tutto accompagnato da varie forme di elettroshock, che riallineava la condotta e rendeva le pazienti più facile da trattare). Quando venne dimessa dal sanatorio svizzero il suo caso fu riassunto come “reazioni a sentimenti d’inferiorità (principalmente nei confronti del marito)” e ambizioni che erano in realtà “autoinganni” che causavano difficoltà nella coppia“. Mentre Zelda era in Svizzera Scott incitò Madame Egorova (l’insegnante di danza n.d.r.) a scriverle una lettera per sgonfiare le sue ambizioni».
Zelda Fitzgerald morta in un incendio in manicomio, Sylvia Plath e Virginia Woolf suicide a cui potrei aggiungere tante altre artiste che nella vita volevano esercitare il proprio talento e il proprio pensiero, una per tutte: Camille Claudel, scultrice e amante di altro scultore passato alla storia – Auguste Rodin – morta in manicomio dopo averci trascorso la vita.
Di donne tacitate, rinchiuse in conventi o manicomi, ostracizzate e ostacolate nelle ambizioni – quando non bruciate sul rogo – nei secoli ce ne sono state tante, troppe. L’autrice sviscera un aspetto dello scrivere nel quale le donne di cui racconta si ritrovano: l’essere uno strumento di costruzione e affermazione identitaria vissuta sull’orlo del dubbio che altri rendono patologia mentale: «Virginia e Vivien(ne) si sentirono dire da familiari e medici che soffrivano di “insania morale”, etichetta attribuita spesso alle ragazze che in un modo o nell’altro si ribellavano alle limitazioni intrinseche al proprio genere (con la promiscuità, spesso, nel comportamento o nel precoce sviluppo fisico)».
A Zelda e Virginia nei periodi di internamento veniva concesso di scrivere per un’ora o due al giorno perché la scrittura, a detta dei medici che le avevano in cura, le sovreccitava, anche nella psichiatria era scivolato il veleno del pensiero aristotelico divenuto centrale nella teologia cattolica per cui le donne sarebbero troppo emotive, fragili, deficitarie delle doti che la Natura ha attribuito agli uomini, delle minus habens.
Zembrano fa notare come a quelli considerati grandi scrittori, Flaubert o Fitzgerald, fosse concessa l’ubriachezza, l’instabilità mentale, la lentezza nel procedere nella stesura dei loro romanzi e l’attingere a piene mani dal proprio vissuto come attributi collegati al genio letterario mentre per le donne, simili o pari comportamenti, venivano stigmatizzati come chiari sintomi di malattia mentale: «Scott a Zelda: stavi impazzendo e lo definivi GENIO. Lei è troppo spesso vista come una trasgressione psichiatrica».
Scrivere della propria vita – se a farlo sono donne- è sintomo di malessere o, se proprio non si riesce a bollarlo come narcisismo patologico utile all’internamento, è cosa da liquidare alla stregua di letteratura di serie B, robetta da donne.
Peccato, però, che quella robetta, che Zembrano definisce materiale grezzo, sia oggetto di saccheggio da parte dei mariti, l’accusa che Francis Scott muoveva con veemenza a Zelda era che lei non potesse fare della loro vita spunto di racconto nei suoi scritti ma lui sì, lui poteva, lui poteva sostituirsi a lei anche nel raccontarla: «Lei vive e lui trascrive».
Anche in questo caso gli esempi non scarseggiano, basti pensare a Colette caduta in depressione dopo il matrimonio con Willy, lo stesso Willy che pubblicò a suo nome il frutto del lavoro della moglie. E anche qui, purtroppo, nulla di nuovo nella storia del doppiopesismo che vede attribuire valori e giudizi diversi a identici comportamenti quando agiti da una donna e da un uomo: «Ciò che in un uomo è visto come segno di grande Arte in una donna può diventare un campanello d’allarme» e ancora «ANSIA: quando la vive lei, è patologica. Quando la vive lui, è esistenziale», sono tanti gli esempi collezionati negli anni che mi si affacciano alla mente come, sono certa, ognuna di noi ne richiama, spesso, dalla memoria.
Zembrano mantiene il focus sulla diagnosi di disturbo mentale perché l’ha vissuta, sa quel che si prova. Cosa ci si aspettava da queste mogli? Che svolgessero un ruolo ancillare, che fossero complementari – così come postulato dalla religione cattolica – che fungessero da levatrici per le opere dell’ingegno dei mariti, che rinunciassero alla folle ambizione di essere a loro volta scrittrici per dedicarsi, anima e corpo, al talento maschile che non doveva essere né offuscato né privato delle attenzioni muliebri. A queste donne veniva ripetuto, fin dall’infanzia: componiti! Stai composta! Il saggio è denso, ricco di richiami letterari e richiede una lettura attenta.
L’autrice si sofferma sul lavoro di donne che non si sono lasciate intrappolare nella categoria di moglie, come Mary McCarthy ed Elizabeth Hardwick, anche se quest’ultima assume una posizione giudicante e critica nei confronti di Zelda che, secondo lei, avrebbe dovuto essere collaborativa e rimanere invisibile invece di cancellare la firma del marito da un racconto da lei scritto.
L’autrice scrive pagine fitte in cui con un gioco costante di rimandi tra romanzi e saggi costruisce un mosaico nel quale il filo rosso è la consacrazione dei generi e delle opere letterarie: «Perché l’espressione di sé, l’implacabile autoritratto, non è una forma d’arte che ha potenziale di legittimità? Perché abbiamo questo concetto per cui scrivere in maniera autobiografica (specialmente se a scrivere è una donna), persino nel contesto di un romanzo, non sia scrivere letteratura?». La risposta arriva qualche battuta dopo: perché il romanzo deve trascendere da sé. L’argomentazione costruita nel saggio vuole confutare quest’assunto. Riprendendo l’interrogativo dell’incipit: chi decide quali sono i generi letterari importanti e degni e quelli che non lo sono? Perché i diari e i blog scritti dalle donne vengono etichettati come sfoghi personali ed esternazioni di pancia? «Essere una donna, forse, equivale a sentirsi sempre un forestiero» se non proprio un forestiero, sicuramente, un ospite tollerato dal quale, per le graziose concessioni ricevute, ci si attende che mostri sempiterna gratitudine senza mai eccedere nella pretesa.
Nel libro ogni riga è autobiografica, l’autrice racconta partendo dalle proprie esperienze di scrittura, dai suoi momenti bui, le cadute, i dubbi, il senso di inadeguatezza, i tentativi e le strategie e dalle sue letture.
Rappresenta la cultura contemporanea nell’uso di linguaggi e strumenti contemporanei come i social, i blog, le connessioni in rete rendendo bene le logiche di una scrittura che procede per immagini, sensazioni, suggestioni e collegamenti mostrando una sua vitalità che, anche se a tratti sincopata e scomposta, è superficiale liquidare come inconsistente declassandola e sminuendola.
La rete offre la possibilità di essere letti, di avere un canale alternativo a quello delle case editrici, di non soccombere alla frustrazione di non poter condividere quella che, per alcune persone, è esigenza vitale: scrivere.
Scrivere come affermazione di sé, come atto rivoluzionario, come percorso identitario che, come negli studi che da anni mi accompagnano, è strumento grazie al qualle le donne raccolgono e tramandano identità e appartenenza non soltanto individuale ma anche collettiva.
Scrivere perché se ne avverte l’urgenza, l’impellenza e la necessità, scrivere perché se non lo si facesse ci mancherebbe l’aria tanto il farlo ci è connaturato e ci definisce. Sono pienamente d’accordo con Zembrano: «Perché gran parte dell’essere uno scrittore, a parer mio, è un fatto di identità” e ancora quando afferma: “Parte dell’occupazione della scrittrice è ancora, forse, l’uccisione dell’angelo del focolare, la lotta alla repressione, come scrisse Virginia Woolf tanti anni fa. Una lotta spirituale contro le brave ragazze che abbiamo dentro (due forze antagoniste: vogliamo scrivere, vogliamo essere amate)».
Poi siamo tutte/i consapevoli degli effetti nefasti che la rete può generare ma quello di cui interessa discutere qui è il come poter utilizzare spazi di condivisione tra menti affini. Un ulteriore aspetto interessante è la critica alle posizioni femministe della seconda ondata per le quali se ti piacciono le scarpe non sei femminista, se spendi i tuoi soldi per vestiti e cosmetici non lo fai per i libri e se curi il tuo aspetto ti stai sottomettendo ai diktat estetici del patriarcato.
No, non è così e – a differenza della Zembrano – non mi sono mai sentita in colpa per il mio interesse per la moda, al contrario, quando ho potuto ho scelto quella creata dalle donne per contribuire a decostruire uno dei tanti doppiopesismi che nel mondo del lavoro vede, in pole position, gli uomini anche nei settori che riguardano la produzione di beni e servizi acquistati da donne.
L’autrice mette a nudo sé stessa, la propria fragilità e la rabbia per quanto le donne del passato, in particolare “le sue mogli pazze”, hanno subito e per il modo, tutto nostro, di massacrarci sezionando ogni scelta, azione, idea, comportamento e atteggiamento, per lo strisciante senso di inadeguatezza, per quel germe della modestia instillato nell’infanzia che impone di non mostrare, ma nascondere, la bravura e conduce sul crinale dell’insicurezza.
Il testo si conclude con l’esortazione rivolta a tutte noi che amiamo scrivere a non lasciarci imbrigliare nel canone letterario vigente accompagnato da un liberatorio: «Serve ben altro tipo di nervi. Per dire affanculo a queste proibizioni interne e sociali che dettano di cosa dovrebbe parlare la letteratura. Fanculo al correlativo oggettivo. Fanculo al canone. Fanculo ai maschi coi loro libroni. Perché, in fin dei conti, dobbiamo essere le nostre stesse eroine». Sipario. Applausi. Un libro da leggere.
©Riproduzione riservata
IL LIBRO
Kate Zambreno,
Eroine
Nottetempo
Traduzione di Federica Principi
Pagine 332
euro 19,90
L’AUTRICE
Kate Zambreno (Chicago, 1977) è autrice di dieci libri. Suoi testi sono stati pubblicati, tra gli altri, su The New Yorker, The Paris Review e Granta. Nel 2021 è stata Guggenheim Fellow per la non-fiction. Insegna Scrittura alla Columbia University e al Sarah Lawrence College. I suoi saggi e romanzi sono tradotti in molte lingue, tra cui lo spagnolo, il francese, il tedesco, il giapponese e il turco. Eroine (pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2012, e riedito nel 2024), ormai libro di culto, è considerato una delle opere di non-fiction più originali e influenti degli ultimi anni.
Inerenti all’argomento tra #ledisobbedienti: