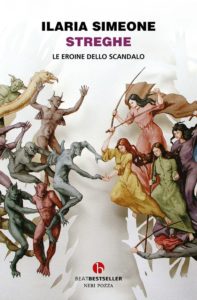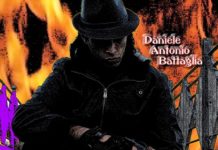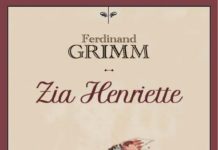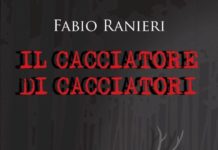«Traviate o pericolanti, meretrici o streghe, licenziose o in crisi coniugale, nel Ducato di Milano ai primi del Seicento, le donne sono da rinchiudere. Se non nei rifugi, nelle salde istituzioni del matrimonio e del convento» scrive Ilaria Simeone in “Streghe. Le eroine dello scandalo” pubblicato da Neri Pozza riportando la contabilità dei pii ricoveri per le anime perse.
Questi, sorti a Milano tra il Cinquecento e il Seicento, erano distinti in base all’appartenenza sociale, il peccato commesso e l’urgenza dell’espiazione della colpa. La caccia alle streghe è uno dei turpi modi in cui le donne che infrangevano le regole sociali della propria epoca venivano castigate.
Le colpe variavano dall’esercizio del sapere botanico per la cura degli infermi all’assistenza alle partorienti e/o alle donne sfinite dalle eccessive gravidanze e l’impossibilità di allevare altri figli che volevano disperatamente evitare ulteriori gravidanze spesso, però, la colpa non riguardava un comportamento, un’attività, bastava l’essere troppo belle, intelligenti e indomite per suscitare brame di possesso o gelosia che potevano sfociare nella vendetta.
Anche le faide, i regolamenti di conti, i complotti e la stupida superstizione erano validi motivi per perseguitare, torturare e uccidere le donne. Se un raccolto andava male, se la carestia sopraggiungeva, se un morbo appestava e mieteva vittime, se un marito tradiva, se un bambino moriva, se i rimedi erboristici somministrati non sortivano effetto, se c’era vendetta da perseguire, se…se…se… c’era sempre la possibilità di accusare una donna di meretricio con il diavolo.
Il Malleus Maleficarum, “Il martello delle malefiche”, pubblicato nel 1487 dal frate domenicano Heinrich Kramer con la collaborazione del confratello Jacob Sprenger offriva l’appiglio giusto, bastava che semplici dicerie fossero riportate per avviare un procedimento: «Maliziose, credulone, di scarsa intelligenza – “per quanto riguarda l’intelletto e la comprensione delle cose spirituali esse sembrano appartenere a una specie diversa da quella degli uomini” –, impressionabili, perfide, impazienti, volubili, hanno la lingua lubrica e smodate passioni. Le donne sono difettose: sono state fatte “con una costola curva, cioè una costola del petto ritorta come se fosse contraria all’uomo. Da questo difetto deriva anche il fatto che, in quanto animale imperfetto, la donna inganna sempre» concetti di aristotelica discendenza che relegano la donna in ruolo subalterno in quanto non solo minus habens ma, anche, pericolosa corruttrice in demoniaca combutta.
A dare manforte agli inquisitori sopraggiunse il testo di Paolo Ghirlando, il trattato De sacrilegiis. Simeone ricostruisce alcuni dei processi noti, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Settecento, concentrandosi sulle storie di tre donne: Caterina de’ Medici, Isotta Stella e Maria Toldina da Pilcante.
Riportando stralci degli incartamenti processuali getta luce su pagine buie del passato in cui la burocrazia – come sempre – registra asetticamente gli avvenimenti, anche quelli più terribili in cui il soggetto, più che l’oggetto, sono le vite delle persone: «Anche questo fu la caccia alle streghe: strage di dimenticate, portata a termine da uomini terribilmente normali», come non pensare alla banalità del male per il cui disvelamento Hannah Arendt fu accusata di tradimento sionista?
Caterina de’ Medici fu dichiarata strega perché l’ultimo dei suoi padroni ad abusare di lei era affetto da coliche che i medici furono incapaci di curare, i fatti si svolsero in quella Milano dove il cardinale Borromeo fece della caccia alle streghe una ragione di vita.
Quella raccontata è un agghiacciante vicenda di cui scrisse anche Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi. Isotta Stella fu torturata, uccisa e abbandonata sotto un cumulo di letame a Triora dove la furia contro le donne vide in contesa le autorità amministrative inviate da Genova, la Superba, e quelle del potere ecclesiastico.
L’accanimento fu tale da spingere a scomunicare – ma solo per due settimane utili a ribadire la supremazia della chiesa – l’inviato investito delle indagini: «Non si tratta più di indebite ingerenze del foro secolare in reati di competenza della Chiesa: sono i metodi e le norme procedurali utilizzati dal commissario a essere sotto accusa. Il cardinale di Santa Severina impone il nuovo punto di vista dell’Inquisizione romana sul delitto di stregoneria, quello che prenderà poi corpo nell’Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum del 1620. Per condannare occorrono accertamento del corpus delicti e prove valutabili; non sono considerate valide le chiamate in correità: inammissibili le deposizioni di streghe confesse contro altre donne viste al sabba. La restituzione delle colpevoli al braccio secolare è prevista soltanto quando il maleficio e i suoi effetti vengono inconfutabilmente provati, cosa davvero difficile. Il cardinale Santoro non è affatto scettico riguardo al potere del Maligno: la pestifera setta di Scribani, però, gli appare come un esercito allo sbando, facile da sconfiggere, quasi sempre, con paternalistiche punizioni. I governi laici non dovevano intromettersi: le coscienze erano di competenza esclusiva del tribunale dell’Inquisizione».
La caccia alle streghe che si consumò a Triora fu una imperdonabile scia di sangue e dolore. La terza donna cui l’autrice restituisce dignità è Maria Bertoletti Toldini uccisa nel 1716, anche quello a suo carico fu un processo farsa ma, questa volta, anche se ci sono voluti trecento anni è in corso una causa in appello promossa dai discendenti degli abitanti del luogo dove visse e morì: il Comune di Brentonico in provincia di Trento. Simeone racconta di donne ingiustamente accusate, torturate e mandate al rogo o morte in carcere: «In tre anni furono arrestate, torturate, condannate al carcere preventivo trentacinque donne e un uomo. Dieci erano state uccise dalle torture, dalla prigione, dalle lungaggini del Santo Uffizio. Sedici, insieme allo stregone, furono probabilmente scarcerate, ma soltanto quattro, di sicuro, fecero ritorno a Triora: nel registro della IX Podesteria risultano le loro date di morte: Franchetta Borelli 2 gennaio 1595, Battestina Augeri 11 gennaio 1598, Franceschina Chiocheto 1° febbraio 1598, Franchetta Ferrandino 23 settembre 1598. È ignoto l’esito del nuovo processo contro la piccola Giovannettina. Di Caterina Cappone e delle tre sorelle Vivaldi Scarella, la banda di Andagna, non si hanno notizie. E nulla si sa della sorte di Giovannina Boffaria, Paolina Bricola, Giacomina Brea, Giacobina Strazzera, Antonina Rosso e Caterina Rosso. Due di loro perirono nelle carceri della Superba e probabilmente lo stesso destino toccò alle altre, sfinite da interrogatori, esorcismi, deposizioni, tormenti e dalla permanenza nei mattatoi di Triora e Badalucco».
Il ricordo delle vite – e le morti – delle streghe di Triora, insieme con tutte le altre, trovano sempre voce tra #ledisobbedienti perché al fine di evitare il ripetersi dei crimini bisogna ricordare, ricostruire, studiare e spiegare quali motivi condussero a certe aberrazioni che nulla hanno di “umano”.
Studiare gli incartamenti processuali è illuminante e propongo un esercizio: una lettura comparata di un processo per stregoneria di secoli addietro e uno – attuale – per stupro. In entrambi ritrovo le stesse sudicie e inaccettabili insinuazioni sul potere corruttivo della seduzione femminile che porta gli uomini alla perdizione, alla momentanea sospensione della ragione che giustifica una larvata – quando non manifesta – difesa costruita sulla responsabilità delle donne per il modo in cui si abbigliano, parlano, camminano e respirano!
Un libro importante, corredato da un bel progetto grafico di copertina, che andrebbe inserito nel programma scolastico di storia. Anche la caccia alla streghe fu una guerra, una guerra condotta dagli uomini contro donne innocenti.
©Riproduzione riservata
IL LIBRO
Ilaria Simeone
Streghe. Le eroine dello scandalo
Neri Pozza
Pagine 192
euro 13
L’AUTRICE
Ilaria Simeone è nata a Napoli nel 1962 e vive a Milano. Giornalista professionista, ha compiuto studi di filosofia, ha scritto guide di viaggio e, con altri autori, ha pubblicato Guida all’Italia misteriosa (De Agostini 2005). Attualmente sta scrivendo un altro libro, sempre dedicato alle donne.
Tra #ledisobbedienti le streghe di Triora e Franchetta Borrelli: